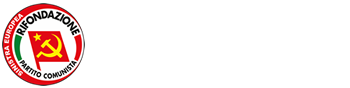- C’è una legge di tendenza storica nel processo di riproduzione del capitale che consiste nel fatto che il suo tasso di rendimento è sistematicamente più alto del tasso di crescita del reddito: i patrimoni ereditati subiscono un incremento continuo rispetto ai redditi da lavoro, con un conseguente aumento della disuguaglianza fra chi vive di ricchezza e chi vive di lavoro (Piketty). Persino il World Economic Forum di Davos, che non è certo un luogo di lotta rivoluzionaria, rende noto che solo otto persone detengono la stessa ricchezza posseduta da 3,6 miliardi di persone, ossia di circa la metà della popolazione mondiale.
Il capitale, dunque, non solo tende a crescere rispetto al reddito, ma anche e soprattutto a concentrarsi in sempre meno mani, blindato nei fortificati templi della finanza. Con la conseguenza particolare che i grandi capitali si mangiano i piccoli. Nasce così una lotta, ma tutta interna alla classe capitalistica, una lotta distruttiva per i gruppi sociali intermedi: piccoli capitalisti, ceti medi più o meno riflessivi, borghesia minore, esponenti delle professioni, quadri privati e pubblici, padroncini e rentiers marginali. Si verifica, in altri termini, una tendenza spinta alla polarizzazione delle classi. Ma l’afasia ormai cronicizzata del movimento operaio e delle sue organizzazioni è tale da vanificare la possibilità di costruire un fronte eterogeneo, ma potenzialmente vasto, di opposizione al paradigma economico-sociale dominante. La residualità dei subalterni – potremmo dire con linguaggio gramsciano – accresce la possibilità di risoluzione pacifica delle contese fra grandi e piccoli capitali. Il rischio, tutt’altro che peregrino, è che alla fine si ricomponga una sintesi di interessi sotto l’egida del grande capitale e che una nuova destra emergente sorga da una sintesi dialettica tra grandi capitali e quel che resta dei piccoli. Con l’altra, letale conseguenza che alla concentrazione del capitale corrispondono un’altrettanto violenta concentrazione del potere, incompatibile con il mantenimento della democrazia, persino nella versione liberaldemocratica, e una compromissione profonda delle libertà, dei diritti e, al limite, della pace. Esperimenti di fascismo in salsa liberista non sono del resto mancati nella storia e non c’è ragione di ritenere che non possano riprodursi oggi. Il fascismo è un virus interno alla meccanica stessa del capitale, che si alimenta delle contraddizioni innescate dalle crisi capitalistiche: c’è un’amara ironia nella potenza della formazione economico-sociale capitalistica giunta al massimo livello del suo sviluppo. - Nei paesi sviluppati, il rapporto di lavoro salariato è ormai giunto al termine e giorno dopo giorno diventa sempre più difficile riprodurlo (Mazzetti). Si determina cioè, nel rapporto di capitale, una non transeunte entropia occupazionale. E ciò in quanto il sistema retto sul rapporto di capitale è andato progressivamente a sbattere contro quello che Marx definì il suo limite “interno”, un limite che rende via via decrescente la remunerazione del capitale in rapporto all’investimento fisso. Tutte le manovre antagonistiche messe in atto per frenare la caduta del saggio di profitto, anche quelle inventate dalla più sofisticata tecnica finanziaria speculativa, non hanno potuto rovesciare la tendenza pluridecennale alla contrazione della crescita in tutto l’Occidente: prosperano i grandi detentori del capitale, periclitano tutti gli altri.
- La tesi classica che ispira le teorie mercatiste è che le cosiddette forze spontanee del libero mercato, quelle della domanda e dell’offerta, debbano determinare i livelli del tasso di interesse, del tasso di profitto e del salario reale, nonché dei livelli di occupazione ottimali che portano l’economia in “equilibrio naturale”: un equilibrio perfetto, dotato dei crismi della scienza; un equilibrio che non ammette variabili indipendenti, men che meno l’interferenza della soggettività politica. Questo significa che se tu lotti per cercare di aumentare il salario oltre il livello determinato dall’equilibrio del mercato, la conseguenza dovrà essere una caduta dell’occupazione e della produzione. In altre parole: il conflitto sociale fa solo danni.
Qui non siamo, con tutta evidenza, nel regno della scienza, ma in quello dell’ideologia, che oscura il dato essenziale e cioè che il mercato non prevede il futuro, ma lo determina secondo gli interessi della classe egemone: una china pericolosa su cui sono purtroppo ruzzolate le organizzazioni sindacali e parti importanti della post-sinistra. Le quali, non a caso, hanno abbandonato la più strategica delle rivendicazioni sindacali, la sola, a ben vedere, capace di affondare i denti nei rapporti di produzione, quella della redistribuzione del lavoro, di una consistente riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. - Continuiamo – giustamente – ad affermare che solo nelle trasformazioni sociali operate dal movimento oggettivo del capitale, un’intelligenza collettiva può trovare condizioni favorevoli per il rovesciamento del rapporto di produzione.
In sostanza, o ti sai portare a quel livello dello scontro o sei destinato a girare in circolo e a soccombere, tornando e ritornando a quel “punto zero” di cui parla con un certo sconforto Giovanni Mazzetti, riferendosi ai nostri perduranti limiti.
Tre linee sono allora da scongiurare: a) il vezzeggiamento verso i piccoli capitali e le loro rappresentanze politiche, intrise delle illusioni del populismo interclassista; b) la tentazione di replicare l’illusione secondointernazionalista – propugnata anche da insospettabili pulpiti della sinistra nostrana – che il movimento oggettivo del grande capitale porti in sé al rovesciamento rivoluzionario dei rapporti sociali; c) l’opzione rinunciataria in base alla quale, di fronte ad un capitalismo che si crede in grado di riprodursi senza autodistruttive contraddizioni, sia in termini economici che di consenso, l’unica cosa da fare per la sinistra è stare al gioco e lamentarsi solo ogni tanto per invocare un po’ di redistribuzione a valle del processo produttivo.
Bisogna allora chiedersi se non occorra individuare una chiave, che divenga anche una parola d’ordine, una sorta di bandiera per l’egemonia. E se questa chiave non possa consistere nella riscoperta della modernità della pianificazione collettiva, affrancata dalla storiografia mainstream del Novecento e ridotta a pura propaganda anticomunista dagli odierni apparati ideologici che la identificano con la stalinizzazione, cioè come un intrinseco fattore distruttivo delle libertà individuali. Per dirla con Brancaccio: “una leva forte, la più forte mai concepita nella storia delle lotte politiche, l’unica potenzialmente in grado di piegare la legge del movimento del capitale prima che ci affossi nella catastrofe, intesa questa volta nel senso inedito e sovversivo di fattore di sviluppo della libera individualità sociale e di un nuovo tipo umano liberato”.
Per farlo occorre superare le nostre pigrizie e tornare ad una discussione che attraversò il movimento comunista europeo dopo la seconda guerra mondiale per essere in seguito sciaguratamente abbandonata. Si tratta, appunto, del rapporto tra piano e libertà, tra proprietà pubblica e proprietà sociale: un terreno ancora tutto da esplorare.
Proprio Karl Marx si occupò di questo tema cruciale. Nella sua riflessione il controllo collettivo della totalità delle forze produttive è condizione per lo sviluppo della totalità delle capacità individuali. Alla base di questa intuizione c’è il progetto di una società in cui i produttori associati, riuniti in libere e democratiche istituzioni, divengano capaci di impadronirsi del proprio destino che il capitalismo invece affida a forze estranee.
La formula che più si avvicina, per approssimazione, a questo ideal-tipo, è scritta nel secondo comma dell’articolo 41 della Costituzione, dove si legge che “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Lo sviluppo progressivo della democrazia e la lotta di classe dovevano inverare tutte le potenzialità intrinsecamente presenti in questo passo della Carta.
La libera espressione dell’individualità si deve manifestare dunque nella repressione della libertà estraniante del capitale finanziario per affidare ad un progetto collettivo la determinazione di “cosa, quanto e per chi produrre”.
Dino Greco
Valeria Allocati
Maruzza Battaglia
Michela Becchis
Fiorenzo Bertocchi
Stefano Cristofori
Frank Ferlisi
Manuela Grano
Tonia Guerra
Ramon Mantovani
Caterina Marchetti
Antonio Marotta
Gianluigi Pegolo
Antonella Piraccini
Giovanni Russo Spena